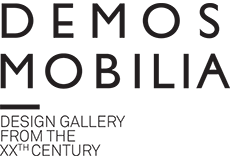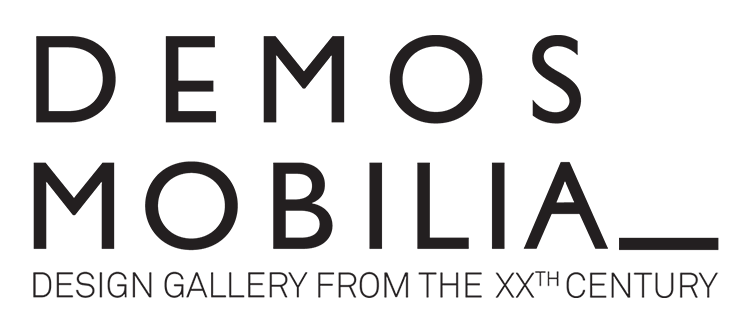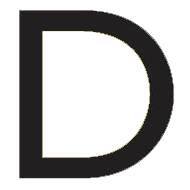Intervista di Hanna Weissfeld per Formlicht – Design, Culture & Future Thinking.
Demos Mobilia ha una storia più che trentennale. Come nasce la
galleria e quale visione l’ha guidata sin dall’inizio?
Ah, cara mia, Demos Mobilia è nata come certe invenzioni fortuite: un po’ per amore, un po’
per necessità, un po’ per rabbia creativa! Io stavo al DAMS (a Bologna), ed avevo pari passione
per i mercatini che per le lezioni. Vedevo oggetti buttati via, veri capolavori, e sentivo che c’era
qualcosa da salvare. Poi è arrivata Veruska, con il suo occhio fulminante e la sua testa piena di
idee e poesia visiva. A quel punto è esploso tutto: il collezionismo, il restauro, il desiderio di
dare dignità alle cose. Il commercio? È venuto dopo, quasi per fame di continuare a cercare.
La Demos è diventato il nostro modo di abitare il mondo. E oggi è ancora così: salviamo
oggetti per salvare storie. E se poi qualcuno li compra, tanto meglio, così possiamo ripartire da
capo!
Demos Mobilia nasce da un gesto istintivo, dalla tensione tra ricerca e necessità di senso.
All’inizio eravamo animati da una domanda: cosa rimane davvero di un oggetto quando il
tempo passa?
La risposta l’abbiamo trovata nell’autenticità dei materiali, nella forza di una linea, nella storia
che un mobile porta con sé. Con un occhio allenato alle forme (grazie agli studi nelle arti
applicate) e un’irrequietezza felice che ci ha sempre spinti a cercare l’essenziale, abbiamo
iniziato a costruire una visione: fare della galleria un luogo vivo, dove la memoria si muove,
non si conserva in formalina. Demos Mobilia è un esercizio quotidiano di attenzione — e sì,
anche di bellezza.
Qual è, secondo voi, il valore di conoscere la storia del design per
affrontare il presente e progettare il futuro?
È come voler costruire un razzo senza sapere cos’è la gravità. La storia del design è la
grammatica di tutto quello che usiamo. È piena di errori geniali, fallimenti gloriosi e intuizioni
profetiche. Chi progetta senza conoscerla rischia di fare una minestra riscaldata o, peggio, una
sedia che ti cade sotto al sedere. Per me il passato è un carburante potente. Non lo guardo con
nostalgia, ma con gratitudine. È l’unico modo per immaginare qualcosa che non sia solo
“nuovo”, ma anche necessario.
Conoscere la storia del design significa entrare in dialogo con chi ci ha preceduti. Ogni oggetto
nasce da un’urgenza, da un contesto, da una visione.
E poi diciamolo: come si può fare grafica, architettura, design — qualsiasi cosa visiva — senza
sapere da dove vengono le forme? La storia è uno strumento di lavoro, non una nostalgia. È
solo conoscendo ciò che è stato — gli errori, le utopie, le rivoluzioni silenziose — che
possiamo progettare con coscienza. E con un po’ di grazia, che non guasta mai.
Molti dei pezzi presenti nella vostra collezione portano la firma di
grandi maestri. Come avviene la selezione?
Allora… il criterio ufficiale è “colpo di fulmine con cervello”. Se un oggetto non ci fa sobbalzare
il cuore e non ci accende una lampadina, non entra. Possiamo anche trovare un pezzo da
museo, ma se non ci parla, non lo vogliamo. Non ci interessano i nomi per fare scena:
cerchiamo oggetti con carattere, con anima. Devono avere qualcosa di risolto e qualcosa di
irrisolto. Perché anche l’inquietudine, quando è ben fatta, è design.
Non selezioniamo per nome o tendenza, ma per significato. Ogni oggetto che entra in galleria
deve avere una voce, deve porre domande, lasciare tracce.
Abbiamo un debole per gli oggetti che ti sorprendono quando li guardi di lato, quelli con
piccoli difetti pieni di senso. La selezione è un esercizio grafico, quasi musicale: ritmo, vuoto,
tensione, armonia. Se un pezzo non “suona”, non entra. Cerchiamo oggetti che sappiano stare
nel tempo, come certi caratteri tipografici: sempre leggibili, mai urlati.
Che ruolo gioca il “bello” nel vostro lavoro quotidiano? E cosa
significa per voi oggi “bello”?
Ah, il bello! Non è mica roba da vetrina. Il bello è come il buon pane: crosta ruvida, mollica
viva. È nei materiali veri, nel segno deciso, nelle proporzioni che ti fanno dire “ah!”. Per me
oggi il bello è qualcosa che regge lo sguardo e anche il peso degli anni. Non è mai banale, e non
è mai solo per farsi notare. Se è solo spettacolo, mi stanca. Il bello vero mi fa compagnia anche
quando la luce è spenta.
Il bello non è mai solo una questione estetica. È profondità, rigore, verità. È quella qualità
silenziosa che affiora nei dettagli: un incastro perfetto, una vite non nascosta, una superficie
che racconta il tempo.
Da sempre diffido del “bello che piace a tutti”. Per me il bello deve inquietare un po’. Deve farti
fermare. Oggi il bello vero è anche coraggioso: non spreca, non ruba la scena, ma costruisce
legami. Come una buona composizione: ti accompagna senza spiegarti tutto.
Demos Mobilia è molto più di una galleria: è un archivio vivo. Come
integrate la ricerca storica con la proposta contemporanea?
Guarda, il nostro magazzino è come un cervello che non dorme mai. Acquisiamo pezzi come
altri raccolgono poesie. Ogni oggetto ha qualcosa da insegnarci, ogni autore è un vecchio
compagno di viaggio. E la storia, quella vera, è sempre contemporanea. Quando proponiamo
un pezzo, non lo facciamo per moda: lo facciamo perché ha qualcosa da dire adesso. L’archivio
è vivo perché noi ci parliamo ogni giorno. E certe volte — ti confesso — ci risponde anche.
L’archivio non è un deposito, è un organismo in movimento. Ogni pezzo che acquisiamo, ogni
autore che approfondiamo, ci aiuta a leggere meglio il presente.
È come fare un collage: la ricerca storica ci dà i ritagli, ma siamo noi a trovare l’equilibrio. Non
cerchiamo la citazione nostalgica, ma la continuità del pensiero. L’archivio vive solo se respira
con il presente. E ogni oggetto selezionato è un tassello che tiene insieme una visione, come le
pagine sparse di un quaderno grafico infinito.
L’aspetto sostenibile è parte integrante del vostro DNA. In che
modo il riuso e la conservazione del design rappresentano un atto
green concreto?
Eh, noi eravamo “green” prima che diventasse verde. Ogni oggetto che restauriamo è un
salvataggio dalla discarica, un antidoto al fast furniture. Ma non lo facciamo per moda: lo
facciamo perché è giusto. Il mondo è pieno di roba inutile che invecchia male. Noi ridiamo
fiato a ciò che ha senso. E poi restaurare è bellissimo: è come dare una seconda possibilità a
un vecchio amico. O, se vuoi, è un po’ come aggiustare il tempo.
Recuperare un oggetto è un gesto radicale. Significa dire no allo spreco, alla produzione cieca,
all’obsolescenza programmata.
Per me è anche una forma di affetto: rimettere a posto un mobile è come curare una parola
dimenticata. La sostenibilità, per Demos Mobilia, non è uno stile, è una grammatica. Un modo
di stare al mondo con più leggerezza e molta responsabilità. È l’unico green che ci interessa:
quello che non si dice ma si fa.
Oggi si parla molto di economia circolare: Demos Mobilia ne è stata
una pioniera. Come si traduce questa filosofia nel vostro lavoro
quotidiano?
Ma noi la ruota l’avevamo già fatta girare! L’economia circolare, per noi, è la regola numero
uno. Non si butta via niente: si ripara, si reinventa, si riusa. Collaboriamo con artigiani che
parlano con le mani, usiamo solo materiali gentili, e trattiamo ogni pezzo con la dignità che si
dà a un vecchio maestro. Per noi ogni mobile ha una seconda (e magari anche una terza) vita.
È un’economia, sì… ma anche una poetica.
Per noi l’economia circolare non è una novità, è il nostro modo naturale di lavorare.
Ogni oggetto che restauriamo, ogni collaborazione con un artigiano, ogni scelta di materiale è
fatta con attenzione e senso. Lavoriamo sull’esistente, usiamo ciò che c’è, valorizziamo quello
che molti non vedono più. È un atto estetico e politico insieme. Un po’ come impaginare bene:
togliere il superfluo, lasciare solo ciò che conta.
C’è un oggetto, una storia o un autore che, più di altri, incarna
l’anima di Demos Mobilia?
Jean Prouvé, senza dubbio. Era un genio con le maniche rimboccate. Ha fatto case smontabili,
mobili per tutti, e tutto con una coerenza che oggi è quasi sovversiva. Era un ingegnere
umanista, un poeta della lamiera. Il suo design è politico, ma non ideologico: è concreto, utile,
giusto. In lui c’è tutto ciò che amiamo: intelligenza, generosità, futuro. Certo, ora i suoi pezzi
costano come una casa, ma vabbè… lui li faceva per tutti. Noi almeno lo ricordiamo così.
Impossibile sceglierne uno. Demosmobilia non è un altare per un singolo nome, è un melting pot generoso e stratificato, dove convivono i lavori dei visionari del passato che hanno rivoluzionato il modo di vivere la casa e di pensare l’arredo non come possesso, ma come estensione del pensiero.
È una costellazione di gesti radicali, invenzioni silenziose, lampi di bellezza funzionale. È il luogo dove Ponti può dialogare con Prouvé, dove un anonimo falegname degli anni ’50 può commuovere quanto un maestro riconosciuto.
La nostra anima non sta in un solo oggetto: vive nella tensione tra tutti.
Ed è proprio così poi che si arredano davvero le case: pescando da tutto quello che ci emoziona, che ci racconta e rappresenta, che ci somiglia.
Qual è la sfida più grande nel raccontare il valore del design storico
in un mondo abituato alla novità a ogni costo?
La sfida è far capire che il nuovo a volte è solo un vecchio mal travestito. Viviamo nell’era del
“subito”, ma il design storico chiede tempo. È come un vino che va decantato. Devi avere
pazienza, voglia di ascoltare. Il nostro lavoro è proprio questo: rallentare il mondo, far sedere
le persone, raccontare le storie dentro gli oggetti. Perché un pezzo con settant’anni sulle spalle
può essere più rivoluzionario di una start-up.
La sfida è far capire che il nuovo non è sempre progresso. E che la lentezza non è un difetto.
Viviamo in un mondo che consuma anche le immagini. Ma il design storico chiede sguardi più
lenti, più profondi. Ogni oggetto racconta un gesto, un’idea, una necessità. Sta a noi restituirgli
la voce. Il nostro lavoro è questo: accompagnare lo sguardo, rallentarlo, offrirgli un altro
ritmo. Come fare una buona composizione: ci vogliono pause e silenzi, non solo effetti.
Se poteste lasciare un messaggio alle nuove generazioni di
designer e collezionisti, quale sarebbe?
Ragazzi, mettete via Instagram per un momento e toccate le cose vere. Andate nei mercatini,
annusate le sedie, parlate con i falegnami. Siate curiosi, non furbi. Non fate oggetti per
vendere: fateli per cambiare qualcosa. E voi collezionisti: non comprate status, comprate
storie. Il design non è una questione di firme, ma di pensiero. E ricordatevi: un buon oggetto vi
migliora la giornata. Un grande oggetto vi cambia la testa.
Domandatevi tutto. E ascoltate gli oggetti.
Non seguite le mode: osservate i dettagli, cercate la coerenza. Collezionare non è possedere, è
custodire. Progettare non è “piacere”, è prendersi una responsabilità.
E un consiglio personale, da – ormai ex- grafica e da donna: usate la bellezza con rispetto. È un
linguaggio potente, ma anche fragile. E soprattutto, abbiate coraggio. Non di strafare, ma di
dire qualcosa di vero.
Demos Mobilia è creato da Demetrio Zanetti e Veruska Gennari
Demetrio Zanetti (1959)
Nato in un minuscolo paese svizzero di 800 anime, cresciuto tra viti d’uva, biciclette scassate e
orologi che ticchettano lenti, Demetrio Zanetti ha sempre avuto il cuore diviso tra il
palcoscenico e il banco da lavoro. A vent’anni si trasferisce a Bologna, dove studia Teatro e
Cinema e calca le scene come attore di teatro per oltre dieci anni. Ma è tra i materiali che inizia
a recitare la sua parte più lunga: quella dell’antiquario visionario.
Da oltre trent’anni è l’anima di Demos Mobilia, restituisce voce e anima a oggetti dimenticati,
con il rispetto del restauratore e la follia del poeta. Lavora con legno, metallo e resina come
fossero personaggi da riscrivere, sempre in bilico tra passato e invenzione.
Per Demetrio, ogni sedia ha un gesto. Ogni tavolo, una battuta. Ogni mobile ben fatto, un’idea
di mondo. E se gli chiedi cos’è il design, ti risponde: “È una forma di teatro. Solo che qui gli
attori sono gli oggetti. E resistono molto più a lungo degli umani.”
Veruska Gennari (1970)
Fondatrice e direttrice di Demos Mobilia, Veruska Gennari è una figura che unisce visione
culturale, senso estetico e profonda competenza nel campo del design storico. Nata nel 1970 e
formata nelle arti applicate e nella grafica, ha costruito negli anni una galleria che è molto più
di uno spazio espositivo: è un laboratorio di idee, un archivio vivo e una piattaforma critica
per ripensare il rapporto tra forma, funzione e tempo.
Guidata da una curiosità instancabile e da una rara capacità di leggere gli oggetti come tracce
di pensiero, Veruska seleziona ogni pezzo con uno sguardo attento alla coerenza progettuale,
all’etica del riuso e al valore culturale. La sua voce, in equilibrio tra rigore e leggerezza, ha
dato a Demosmobilia una riconoscibilità precisa nel panorama del mid century modern
design: uno spazio dove il passato non si conserva, ma si trasmette.